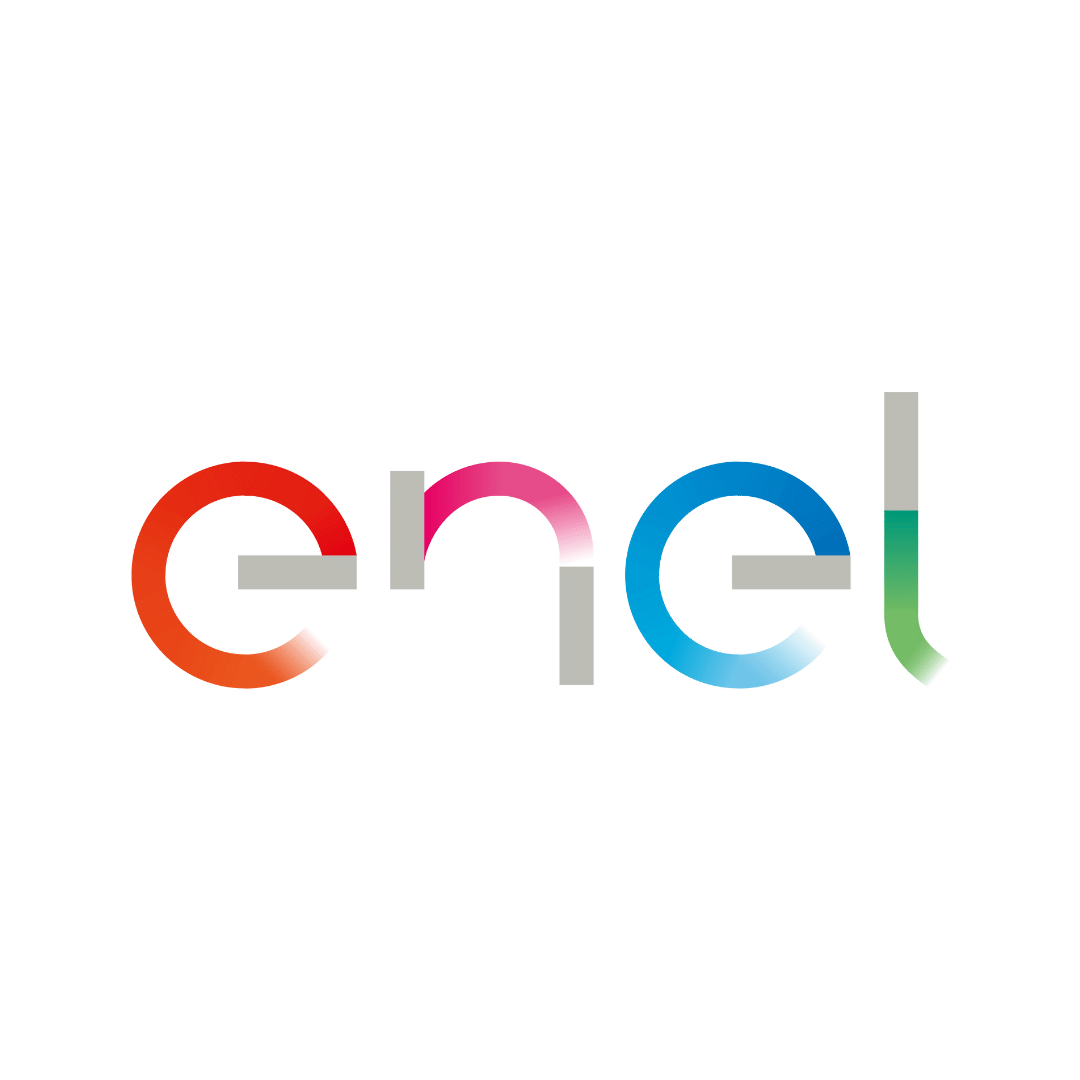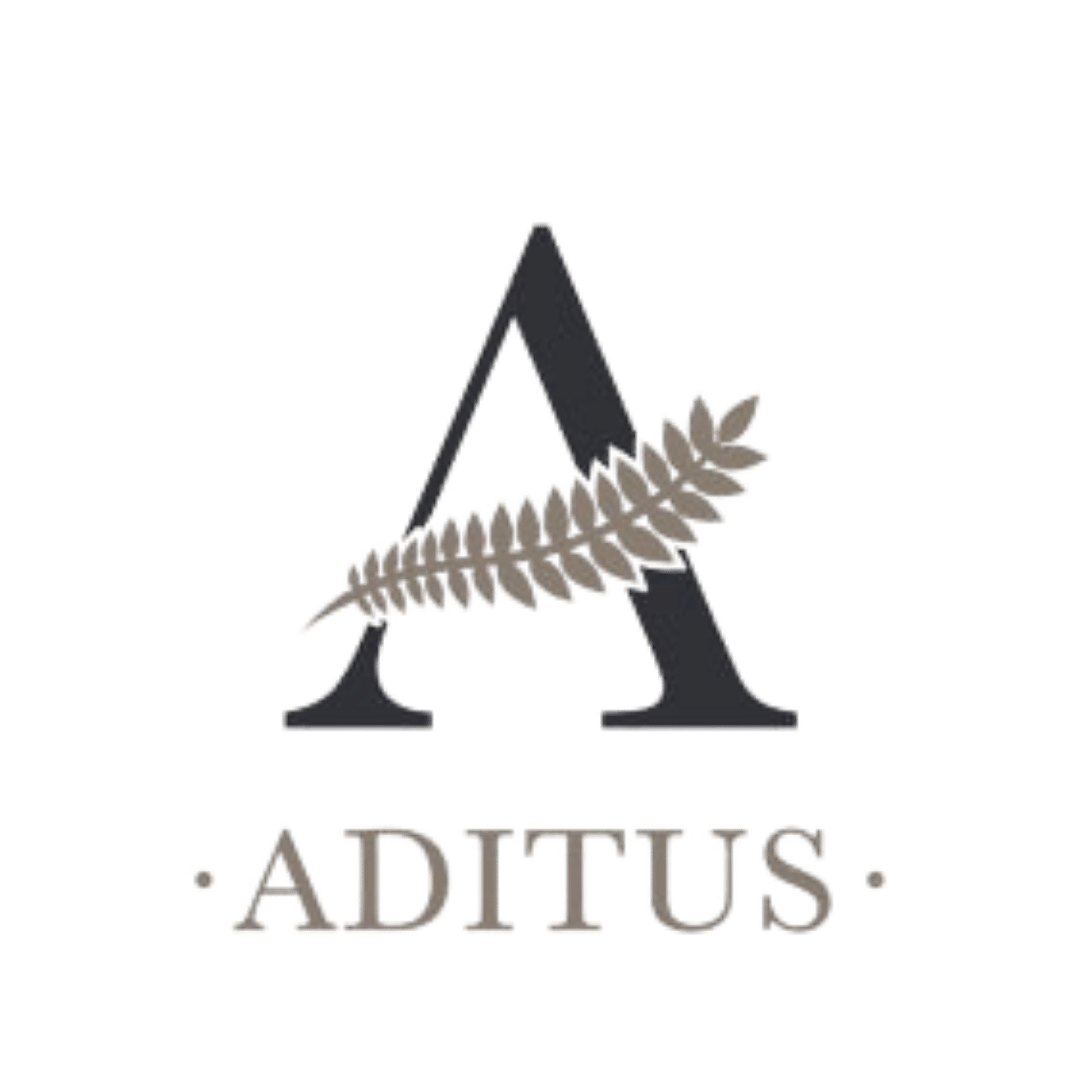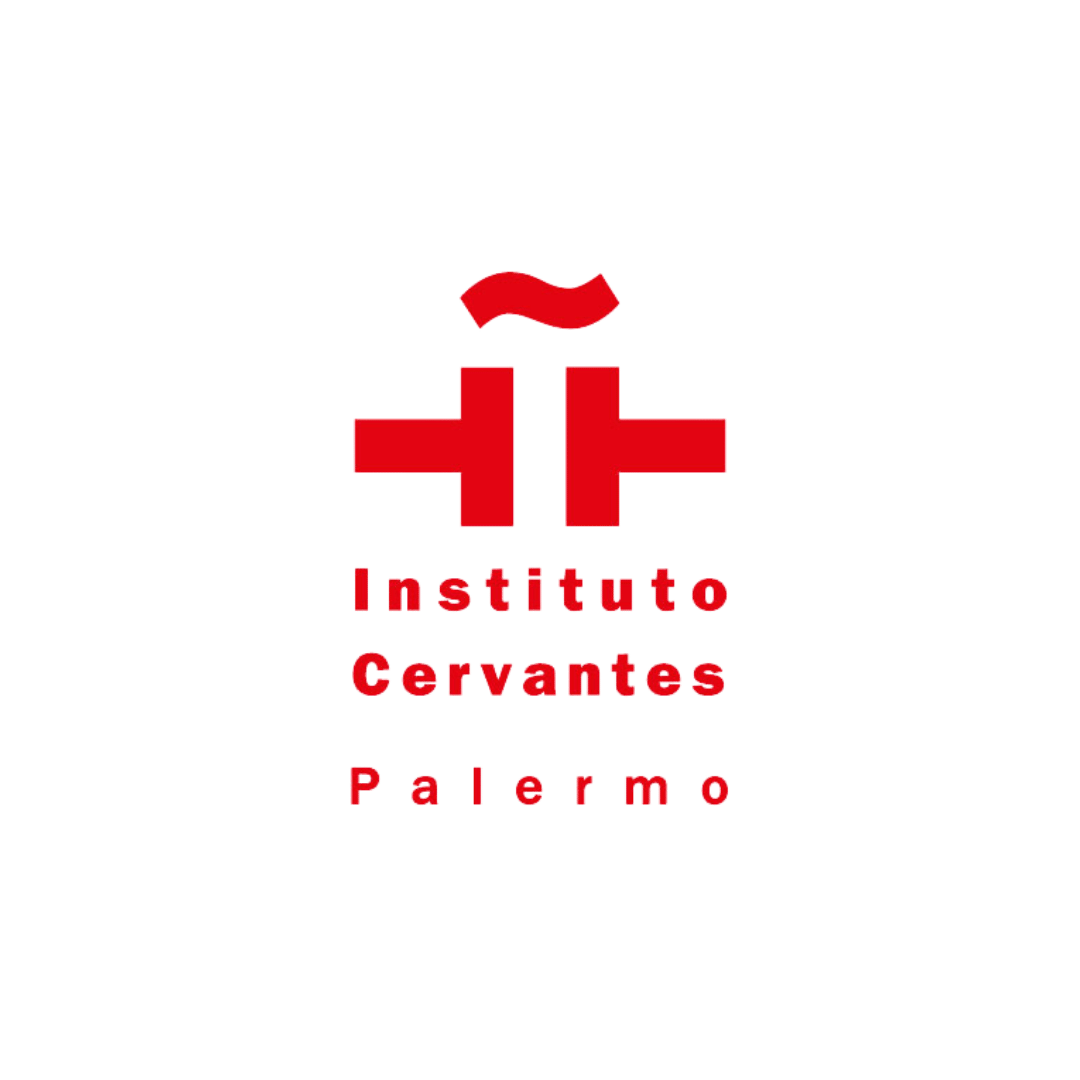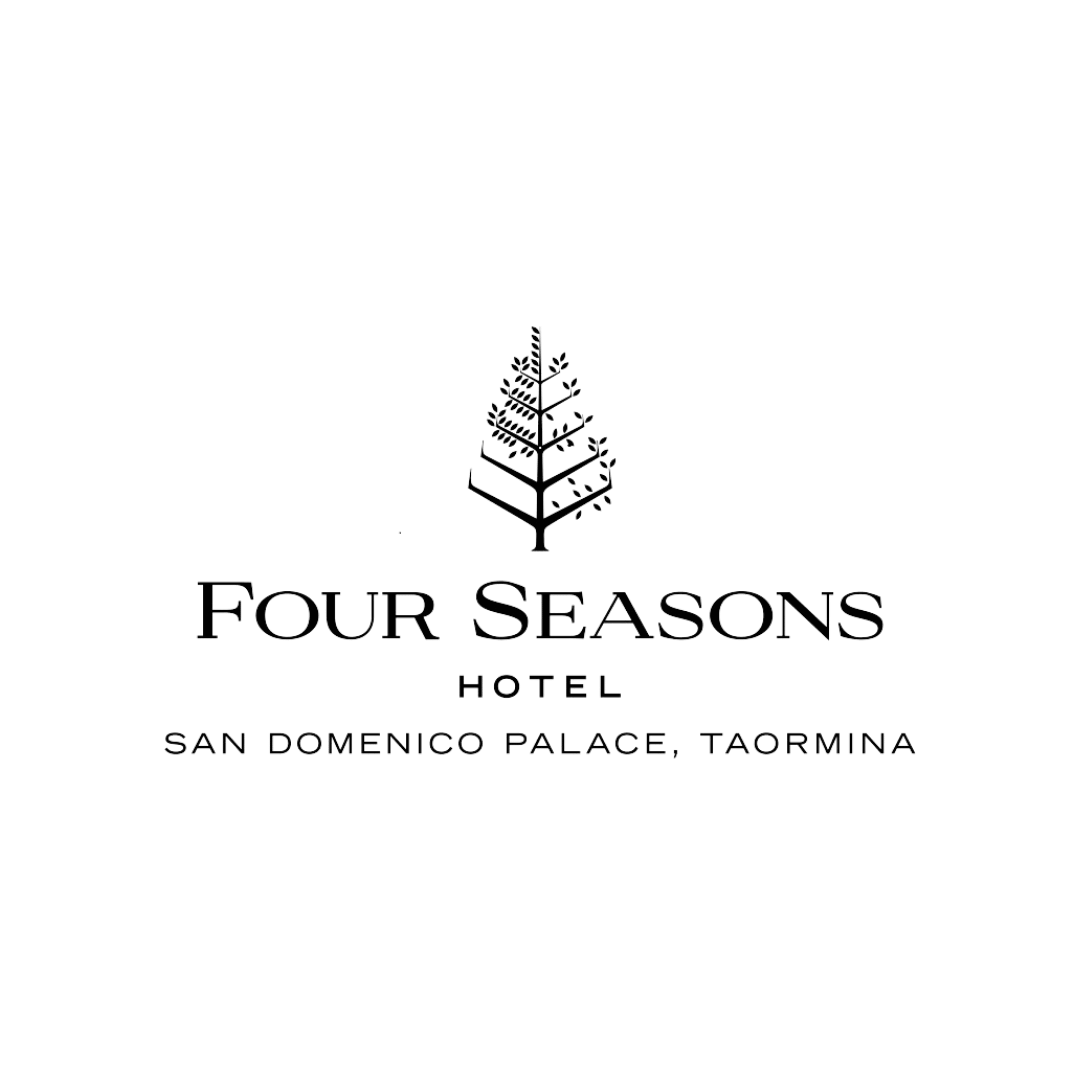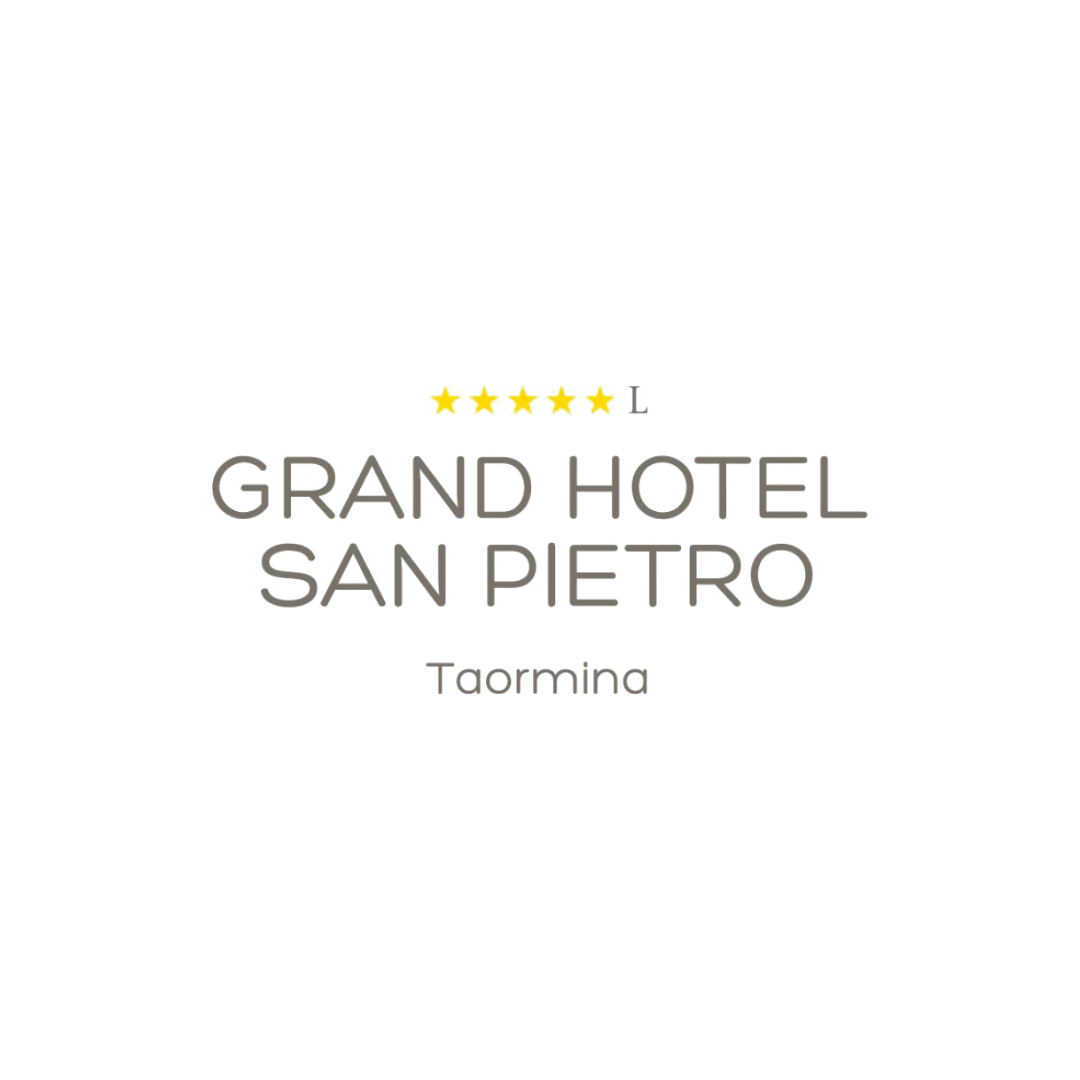Tutta la produzione di Paul Auster è un canone inverso che dimostra con quanta sovrumana indifferenza il Fato raramente premia e più spesso tende agguati senza scampo. Lo raccontava a Taobuk riassumendo il senso ultimo del libro-mondo “4321”: è la caducità del destino a segnare appunto il primato dell’immaginazione, l’unica capace di aprire le sliding doors di infinite possibilità e rovesciare la casualità che spazia via progetti e sogni. Quante volte, rileggendo i suoi libri, mi sono ritrovata a ridefinire la valenza dell’imponderabile nella vita di ognuno, nella mia vita. Così come non dimenticherò, e chi c’era non dimenticherà, quel fine settimana di giugno. Sentire parlare di letteratura e politica il padre del postmodernismo, coglierne la cosmica eppure composta solitudine. Sembrava di respirare il nostro Leopardi, amatissimo da Auster, quasi a perpetuare quella sentenza per cui la natura matrigna è implacabile, quando prende ma anche quando dà. Un pessimismo, però, affatto rinunciatario né rassegnato, se ha spinto l’autore di capolavori come “L’invenzione della solitudine” e “Invisibile” a combattere in prima linea battaglie per i diritti e le libertà civili, a baluardo della democrazia nordamericana. All’umanità in balia dell’imprevedibile non resta infatti che un inclusivo afflato di solidarietà, come agli antieroi della “Trilogia di NewYork”, sperduti nella notte di una metropoli tentacolare, metafora del violento villaggio globale che aspirerebbe ad essere finalmente pacificato per dare tregua ad esseri umani che non hanno certo bisogno di ostacoli ulteriori rispetto a quelli orditi dal capriccio della sorte.